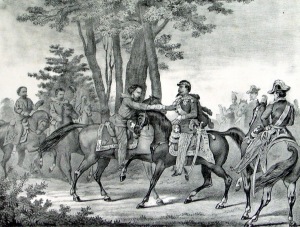La fortezza e il borgo di Vairano Patenora (CE)
La fortezza di Vairano Patenora resiste lassù dalla fine del IX secolo. Il suo nome entrò nella storia agli inizi del secolo successivo, all’epoca del sovrano normanno Guglielmo II e dell’imperatore Enrico VI di Svevia, che lo assegnò all’abate di Montecassino, Roffredo dell’Isola, il 20 maggio 1191. Scontenti della decisione regia, i Vairanesi – fieri eredi degli antichi popoli degli Opici, dei Sanniti, dei Sidicini vissuti nelle “Terre di Vario” e passati dalla dominazione romana a quella longobarda senza mai farsi completamente annientare – decisero di opporsi a tale opposizione e, affidatisi alla guida del conte Ruggero di Chieti, resistettero all’assedio posto alla loro città e sconfissero, durante la battaglia della notte tra il 7 e l’8 agosto 1193, le truppe alleate dell’abate Roffredo e dell’imperatore Enrico VI scoraggiando definitivamente le loro mire. Negli anni successivi, invece, la fortezza di Vairano accolse con profondo spirito di ospitalità personaggi illustri, protagonisti della storia della nostra Patria: gli imperatori Federico II di Svevia e Carlo II d’Angiò e il papa Gregorio X, tra i tanti. Risale a quel periodo l’antica chiesa di San Tommaso apostolo (XIV secolo). Di nuovo subì attacchi e saccheggi (noto quello del 1437 da parte delle truppe del Patriarca Vitellesco, inviato del papa Eugenio II) e assedi nel quindicesimo secolo: epica la resistenza dei Vairanesi durante l’assedio posto dall’esercito di Giovanni d’Angiò intorno alla fortezza, che resistette indefessa e si mantenne fedele al re di Napoli, Ferrante I d’Aragona. Dopo aver subìto la distruzione pressoché totale a opera delle truppe di Marino Marzano, Vairano e la sua fortezza trovarono la forza di risorgere dalle proprie ceneri grazie al barone Innico II d’Avalos. Lo spirito era tornato a essere talmente alto che chiamarono Marzanello il nuovo borgo costruito a mo’ di avamposto del borgo di Vairano, ove si trova la chiesa di Santa Maria di Loreto (XVI secolo).*)

Il borgo è circondato da mura, intervallate da quattordici torri, all’interno delle quali si accede attraverso Porta Oliva, Porta di Mezzogiorno e Porta Sant’Andrea.

La fortezza di Vairano Patenora è composta da quattro torri, di cui la più massiccia è detta torre “mastra”: all’interno, ormai quasi completamente distrutto, sono ancora visibili la suddivisione dei piani, le cucine, le carceri e l’antica cisterna.
Nel XVIII secolo sorsero, lungo la via Latina e la via Venafrana, numerose taverne per la sosta e il cambio dei cavalli di postini e viandanti: tra queste vi era anche la Taverna della Catena, edificata dal duca Domenico Mariconda intorno al 1720, che deve il suo nome al fatto che, quando i re borbonici si recavano a caccia nella vicina riserva di Torcino, l’incrocio veniva sbarrato da una catena.
http://youtu.be/dMWc_xnhOn4 “Il Reggente” è un’opera in tre atti che Saverio Mercadante (Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante, nato ad Altamura il 17 settembre 1795 e deceduto a Napoli il 17 dicembre 1870) compose su libretto scritto da Salvadore Cammarano e basato – come “Il ballo in maschera” di Giuseppe Verdi – su Gustave III. ou Le bal masqué di Eugène Scribe. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Regio di Torino il 2 febbraio 1843 sotto la direzione di Giovanni Battista Polledro…la più recente (ovviamente non tutta!) è stata eseguita dalla Fanfara del XII Battaglione Carabinieri Sicilia, integrata da cinque validi elementi della Fanfara del X Battaglione Carabinieri Campania, sotto la direzione del Maresciallo Capo M° Paolo Mario Sena.
La giornata del 26 ottobre 1860 vide nuovamente Vairano Patenora protagonista della Storia…come risulta dal rapporto giornaliero del “Diario storico dell’Archivio del Ministero della Difesa”: “… A Taverna della Catena, S.M. il Re, che col suo quartier generale marcia colle truppe del quarto Corpo, è incontrato dal gen. Garibaldi…” **) Giuseppe Garibaldi, come risulta da un articolo pubblicato nientemeno che sul quotidiano britannico The Times del 6 novembre 1860, aveva trascorso la notte presso una casa rustica, circondata da una dozzina di pioppi appena fuori Calvi nei pressi del bivio di Taverna della Catena***) : il generale si fermò al bivio, dove arrivarono la colonna delle truppe regie e il re stesso, che salutatolo, procedette a cavallo con lui verso Teano, dove si separarono. ****)

Inno di Garibaldi: testo scritto dal poeta Luigi Mercantini (1821-72) su richiesta del generale Giuseppe Garibaldi perché divenisse l’inno del futuro corpo di volontari denominati Cacciatori delle Alpi: “Voi mi dovreste scrivere un inno per i miei volontari! Lo canteremo andando alla carica e lo ricanteremo tornando vincitori!” Luigi Mercantini scrisse dunque Canzone italiana e ne affidò la composizione ad Alessio Olivieri, direttore della Musica del II Reggimento di Fanteria “Brigata Savoia”. L’inno divenne ben presto assai popolare e conosciuto come Inno di battaglia dei Cacciatori delle Alpi: dopo la Spedizione dei Mille si diffuse enormemente come Inno di Garibaldi.
Qui l’Inno di battaglia dei Cacciatori delle Alpi (Inno di Garibaldi) viene eseguito, paradossalmente, dalla Banda Musicale della Gendarmeria Vaticana, diretta dal M° Giuseppe Cimini, nel cd 1861 – 2011 Omaggio all’Unità d’Italia 150° Anniversario http://youtu.be/4knBnsbExxU
Per tanti anni, in seguito a una relazione del 1926 – priva del timbro del Ministero della Difesa e peraltro non presente negli archivi del medesimo, ratificata soltanto dal Fascio teanese e dunque priva di basi storiche e storiografiche – ci è stata propinata la storiella dello storico incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II presso il Ponte San Nicola sito nell’attuale frazione teanese di Borgonuovo a soli duecento metri dall’odierno Comune di Caianello (che recentemente ha rivendicato la sua “parte”, ma che all’epoca dei fatti e per molti decenni a seguire era costituito soltanto da casolari o casupole sparse nel territorio e dunque non preso in considerazione nemmeno nei successivi “falsi”) ed è raccontato nei libri di storia con il nome di Incontro di Teano.
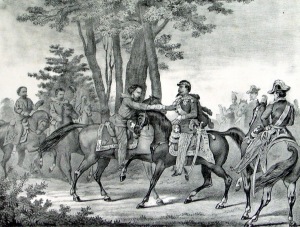
Il generale Giuseppe Garibaldi e il re di Sardegna Vittorio Emanuele II si incontrano, sotto i pioppi che circondano la Taverna della Catena, presso Vairano Patenora il 26 ottobre 1860: il Meridione d’Italia passa così dal Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna…
Ora finalmente persino l’Istituto Enciclopedico Treccani ******) fissa proprio negli stessi luoghi che avrebbero poi “ospitato” per due giorni Antonio Gramsci, illustre prigioniero politico di passaggio verso la casa circondariale di Campobasso (subito dopo l’evento in questione, la Taverna era stata infatti trasformata in una importante caserma dei Carabinieri da cui partivano anche spedizioni contro il brigantaggio http://youtu.be/Uw4cO5fTk2E Li chiamarono briganti: film in cui recitano come comparse alcuni carabinieri appartenenti alle fila della Fanfara della Scuola Allievi Carabinieri di Roma e del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo), lo storico incontro tra il Generale e il Re che segnò l’immediato taglio delle catene che conducevano alle proprietà dello Stato Borbonico di Torcino e Mastrati – che sarebbero poi state svendute,tramite prestanome, ad agrari assenteisti e sfruttatori *******) – e, secondo l’opinione di molti, l’immediato e irreparabile rallentamento di uno dei più importanti interventi di sviluppo autonomo del Sud che era stato la prima ferrovia Portici-Vairano Scalo (Caianello) realizzata dai Borboni.
“Iddio preservi il Re per lunga e lunga età, come nel cor ci sta: viva Fernando il Re! Iddio lo serbi al duplice trono dei Padri suoi, Iddio lo serbi a noi! Viva Fernando il Re!” http://youtu.be/s2S4srrTgeg La Banda dell’Arma dei Carabinieri esegue l’elaborazione a cura del Colonnello M° Vincenzo Borgia dell’Inno al Re delle Due Sicilie, scritto e musicato da Giovanni Paisiello. Dirige il Tenente Colonnello M° Massimo Martinelli.
L’Inno al Re era l’inno nazionale del Regno delle Due Sicilie: non si sa con certezza quale fosse il testo esatto che nel tempo subì diverse modifiche, poiché il nome riportato nel testo, cambiava ogni volta che veniva incoronato un nuovo sovrano, ma è stata ritrovata una partitura contenente anche il testo dell’inno datata tra il 1835 e il 1840. La partitura prevedeva l’esecuzione con soprano e basso come parti di canto, accompagnate da flauti, clarinetti in do, oboi, corni in fa, trombe in do, fagotto e serpentone. Quella che segue è la prima versione dell’inno, in cui “Fernando” fa riferimento al regno di Ferdinando I delle Due Sicilie. La seconda strofa sembrerebbe confermare l’ipotesi che l’inno fosse in realtà stato composto prima della formazione del Regno delle Due Sicilie avvenuta nel 1816, quando i due regni erano separati in Regno di Napoli e Regno di Sicilia, come si rileva nella frase “serbi al duplice trono”.
Il re di Sardegna Vittorio Emanuele II di Savoia, occupando lungo il passaggio verso il Meridione i territori dello Stato Pontificio nelle Marche e nell’Umbria, si era recato incontro al generale Giuseppe Garibaldi – che aveva completato la conquista del Regno delle Due Sicilie respingendo il tentativo di controffensiva da parte dell’esercito borbonico nella Battaglia del Volturno – con il reale scopo di impedire che la Spedizione dei Mille continuasse fino alla Presa di Roma poiché, secondo i consiglieri di Casa Savoia, questa avrebbe provocato l’intervento di Napoleone III e messo a repentaglio le conquiste territoriali sinora ottenute. In cambio della sua “resa” e del suo “buen retiro” a Caprera il generale, noto come l’Eroe dei Due Mondi, ottenne che ai volontari garibaldini fosse concesso di entrare, seppure dopo una severa selezione, nell’esercito regolare sardo mantenendo il grado rivestito nel corso della Spedizione medesima. L’Incontro di Taverna della Catena rappresentò di fatto l’adesione del generale alla politica di Casa Savoia e deluse profondamente le aspettative di quanti auspicavano la fondazione di una repubblica meridionale di stampo mazziniano, che avrebbe dovuto in seguito estendersi anche ai domini papali e alla stessa Roma, come inizialmente idealizzato e persino progettato. Una sorta di resa…dunque…persino Garibaldi e i suoi Mille si arresero *******) , ma i Vairanesi no!
Vairanum acriter impugnans, in nullo profecit: quando Vairano ci si mette d’impegno…non ce n’è per nessuno (detto in breve e in termini moderni).
*) Nel 1590 Vairano fu acquistata dal barone Antonio Mormile di Frignano Cacciapuoti e nelle mani della sua famiglia rimase fino alla caduta del feudalesimo avvenuta nel 1806. L’ultimo barone di Vairano fu Angelo Cacciapuoti morto il 3 maggio 1960
**) Giuseppe Garibaldi cento vite in una – Nino D’Ambra – Ed. A.G.Grassi, Napoli 1983
***) Nuova documentazione sull’incontro del 26 ottobre – PDF – testo originale e traduzione in italiano – Adolfo Panarello
****) Da Quarto al Volturno – Giuseppe Cesare Abba “Memorialisti dell’Ottocento” I a cura di Gaetano Trombatore – Riccardi Ricciadri Edit., Napoli; lapide marmorea affissa nel 1911 per iniziativa della Provincia di Terra di Lavoro e con la grande partecipazione unitaria di Teano e Vairano; http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taverna.jpg#mediaviewer/File:Taverna.jpg http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taverna1.jpg#mediaviewer/File:Taverna1.jpg http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taverna2.jpg#mediaviewer/File:Taverna2.jpg http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taverna3.jpg#mediaviewer/File:Taverna3.jpg; Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 6 aprile 1967 http://it.wikipedia.org/wiki/File:Taverna4.jpg#mediaviewer/File:Taverna4.jpg; Storia d’Italia – Indro Montanelli – Ed. Fabbri, Roma 1994; Discorso alla Camera dei Deputati in occasione del Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi – deputato Valerio Zanone; Garibaldi. Battaglie, amori, ideali di un cittadino del mondo – Alfonso Scirocco – Ed. Laterza, Roma 2001;
******) Incontro di Teano e Teano: Un incontro mancato – Istituto Enciclopedico Treccani – Treccani.it
******) http://altocasertano.wordpress.com/2010/10/25/vairano-patenorace-150%C2%B0-unita-ditalia-ass-angelo-broccoli-interviene-su-incontro-di-teano/
*******) Il 29 agosto 1862, durante la “Giornata dell’Aspromonte” l’esercito regio fermò nuovamente il tentativo di Giuseppe Garibaldi e dei suoi volontari di completare la marcia dalla Sicilia verso Roma per scacciarne papa Pio IX, cosa che sarebbe poi avvenuta soltanto il 20 settembre 1870 (Breccia di Porta Pia).